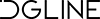Di chi sono gli occhi attraverso cui i popoli osservano il mondo? La risposta è semplice: sono quelli della stampa, dando a questa parola un significato ampio, che lo rende sinonimo di media. Ma secondo la tradizione ottocentesca e novecentesca, qual è la funzione della stampa? Quella di fare da contrappeso al potere esecutivo, rendendosi esso stesso “Quarto Potere”, in aggiunta agli altri tre poteri istituzionali, propri dei sistemi liberali. Se così è nella tradizione storica, va da sé che quegli occhi dovrebbero osservare il mondo mettendosi dal punto di vista dei popoli.
Ma la tradizione storica si è sempre scontrata con la prassi sociale, per il sol fatto che, ad un certo punto, il peso di uno dei due poteri ha cercato di soffocare l'altro. Uno scontro antico quello tra governi e stampa, che lungo il novecento ha avuto momenti parossistici in tutte le società. Uno scontro che si è, in alcuni paesi più che in altri, trasformato in incontro e poi osmosi, dove i governi hanno ridefinito lo statuto della stampa, secondo tradizione, per irreggimentare l’informazione alle esigenze di agenda dei governi.
Se esiste oggettivamente una distorsione tra la missione della stampa e le prassi sociali che essa persegue è anche vero che questa patologia, generatrice di varie sindromi, diventa sistema nelle società anomiche del mondo contemporaneo: terzo e quarto mondo, ma anche Europa dell'Est e del Sud. In questa direzione, la storia italiana diventa paradigmatica, relativamente al fatto che il modello di società italiana uscito fuori dalla seconda guerra mondiale, era portatore di germi anomici, che non solo condizionarono l'evoluzione dell'editoria, ma soprattutto l'evoluzione della società stessa.
Il peccato originale fu che gli editori italiani, dal dopoguerra in poi, si caratterizzarono per non essere editori puri, anzi, per dirla ancora meglio, si caratterizzano per fare un uso della stampa finalizzato ad altri interessi imprenditoriali. E' gioco forza che ribaltato il paradigma del “cane da guardia al potere esecutivo”, gli occhi con cui quella stampa ha sempre osservato il mondo non hanno potuto posizionarsi rispetto al punto di vista dei popoli, ma a quello dei governi.
Due le fasi storiche analizzate: gli anni cinquanta, del XX secolo, dentro lo scandalo Montesi, e gli anni dieci del XXI secolo, affondato dalla post-verità sui processi migratori.
Biografia dell'autore
Marco Marano
Appassionato di drammaturgia teatrale fin dall'adolescenza, ho iniziato il viaggio con la scrittura giornalistica nella fase universitaria, collaborando con settimanali e mensili di cultura sociale. Ma è con l'esperienza di un quotidiano della sera, alla fine degli anni ottanta, che ho sperimentato il giornalismo di strada, lavorando nella cronaca giudiziaria ed in giro per il territorio etneo, alla scoperta dei sistemi pubblici a gestione mafiosa. In quegli anni si aggiungevano, prima, la collaborazione con una compagnia teatrale, dove mi sono cimentato come autore, poi la collaborazione alla Cattedra di Sociologia delle comunicazioni di massa, dell'Università di Catania, dove mi sono immerso negli studi di Semiotica dei media, nel tentativo di ricercare una possibile catalogazione dei linguaggi. Lì, oltre ai seminari diadattici, e ad una ricerca sui processi in Tv, ho elaborato format radiofonici e televisivi, in modo sperimentale, che in seguito ho realizzato per piccole realtà mediatiche locali. Verso la fine degli anni novanta, declinando una di queste sperimentazioni, ho gestito un progetto editoriale indirizzato alle comunità di terzo settore, utilizzando un format cartaceo, a scadenza mensile, ed uno televisivo, a scadenza settimanale.
Trasferitomi a Bologna, ho avviato una collaborazione con una rivista on-line di cultura sociale, e contemporaneamente mi sono occupato di curare l‘ufficio stampa di un'associazione di promozione sociale italo-brasiliana, riguardo i minori delle favelas. In collaborazione con una casa editrice, ho poi condotto laboratori di giornalismo sociale post universitario, confluiti in un progetto editoriale on-line. Nel 2011 ho avviato il progetto di giornalismo web Radio Cento Mondi, con l'obiettivo di leggere la realtà, attraverso fonti slegate dall'osmosi governativa, che è confluito, dieci anni dopo, dentro tre lavori di saggistica narrativa. Ma durante gli anni dieci, sono anche ritornato all'amore di sempre: il giornalismo di strada. Ho collaborato con una rivista on-line romana, per inchieste sullo sfondo del caso Aemilia e sui processi d'integrazione interculturale. Ambito, quest'ultimo, che ho praticato, sul territorio bolognese, con la collaborazione di alcune comunità nazionali, attività che mi ha consentito di condurre dei laboratori di giornalismo interculturale, nel sistema scolastico dell'alternanza scuola-lavoro. Negi ultimi anni mi sono, appunto, dedicato alla saggistica narrativa, in particolare allo studio di eventi storici del dopoguerra italiano, raccontati dai quotidiani dell'epoca, e rielaborati al presente, nella logica dell'analisi storica dell'informazione.