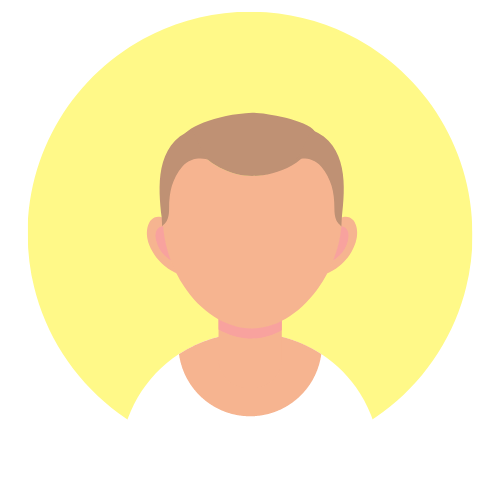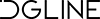Con rigore filologico e chiarezza argomentativa, l’autore ripercorre le principali tappe attraverso cui la Chiesa ha progressivamente elaborato la propria autocoscienza come Corpus Christi, comunità visibile e invisibile, realtà istituzionale e mistero di comunione. L’indagine si sviluppa poi lungo le direttrici storiche e teologiche che attraversano l’età post-costantiniana, la stagione carolingia e il confronto con la tradizione ecclesiale d’Oriente. Vengono analizzati con finezza esegetica e teologica i temi centrali del primato romano – dalla figura di Pietro alla teorizzazione delle duae potestates – e del rapporto tra Chiesa e impero, nonché l’evoluzione della liturgia come locus privilegiato dell’autocomprensione ecclesiale. Un merito di questo studio è la comparazione sistematica tra la tradizione occidentale e quella orientale, quest’ultima caratterizzata da una visione fortemente mistica e sacramentale della Chiesa, fondata sulla liturgia, sull’esperienza della divinizzazione e sull’autonomia sinodale delle Chiese locali. Ciò che emerge è una narrazione chiara e articolata dello sviluppo dell’identità ecclesiale: da realtà spirituale radicata nell’Eucaristia a istituzione progressivamente strutturata attorno alla figura del papa come garante dell’unità e della verità. L’autore riesce a tenere insieme, con equilibrio, la dimensione storica e quella teologica, offrendo al lettore uno strumento utile per comprendere le radici profonde delle questioni ecclesiologiche che segnano ancora oggi il cammino della Chiesa. Attraverso un’accurata analisi delle fonti patristiche, conciliari e canoniche, si mostra come la Chiesa abbia vissuto per secoli secondo una logica di comunione tra Chiese locali, in cui il primato romano era esercitato come servizio all’unità della fede e non come supremazia giurisdizionale. Ne emerge un modello ecclesiologico profondamente comunionale, in cui la struttura sinodale non è accessoria, ma costitutiva della vita ecclesiale. La riscoperta del concilio come luogo effettivo di discernimento e la valorizzazione della corresponsabilità dei vescovi e del popolo di Dio restituiscono al presente una visione della Chiesa meno piramidale e più partecipativa. Inoltre, il confronto con l’ecclesiologia orientale, fondata sulla sinodalità e sulla liturgia come spazio di comunione, offre importanti spunti ecumenici e invita a ripensare il primato petrino in termini di custodia della comunione, più che di esercizio giuridico (dalla prefazione).
Biografia dell'autore
Giuseppe Tartamella